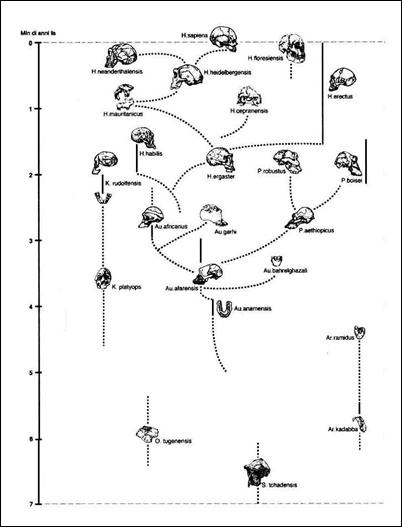“La
scienza va dritta e veloce per la sua strada; ma le rappresentazioni
collettive non stanno al passo, sono arretrate di secoli, mantenute stagnanti
nell'errore dal potere, dalla grande stampa e dai valori d'ordine” (Roland Barthes, Miti d’oggi, 1957) Se
sostituiamo TV a “grande stampa” temo che le
parole di Barthes siano di grande e tragica attualità. Nel
caso di Darwin di secolo ne è passato uno e mezzo e le rappresentazioni
collettive dell’evoluzione sono davvero ferme a prima della rivoluzione
darwiniana e la parola rivoluzione, con l’aiuto di Barthes, forse ci aiuta a
capire perché. Da
un certo punto di vista attribuire uno spirito rivoluzionario a un
benpensante conservatore come Sir Charles Darwin può essere paradossale, ma
non si può negare che Darwin ha proposto nuove rappresentazioni che
sovvertivano i principi dell’ordine sociale del suo tempo (come avevano sicuramente
sovvertito i suoi). LA
RIVOLUZIONE DARWINIANA Dire
che l’adattamento era l’effetto e
non la causa, “causa finale” la
chiamava Aristotele, del cambiamento delle specie è un ribaltamento di 180
gradi di prospettiva, in questo senso una rivoluzione Una causa finale, un
fine, inevitabilmente richiede un soggetto che, per quel fine, opera dei cambiamenti. Se a cambiare è il mondo
naturale, questo soggetto non può che essere una divinità che alla natura è
sovraordinata in quanto potenza creatrice; perciò l’eliminazione del fine
porta a due possibili soluzioni: o la natura si identifica con la divinità
(il Dio immanente di Spinoza) o la natura è retta da leggi di funzionamento e
non da fini che presuppongono una mente trascendente. L’abbandono
del finalismo è già presente nei Taccuini segreti che Darwin scrive appena
tornato dal suo viaggio attorno al mondo nel “Quando uno vede i capezzoli
sul petto di un uomo, non dice che abbiamo un qualche uso... Se si trattasse
di una semplice creazione, di certo sarebbero nati senza”
(Taccuino B) La
critica di Darwin consiste nel “falsificare” sulla base di osservazioni il
creazionismo come spiegazione della natura. Ma è da un punto di vista
epistemologico che Darwin è insoddisfatto di quella che gli appare come una non spiegazione: “In passato gli astronomi avrebbero potuto
affermare che Dio dispose affinché ciascun pianeta si muovesse seguendo il
proprio particolare destino – allo stesso modo Dio dispone che ciascun
animale sia creato con una certa forma in una certa regione. Ma quanto più
semplice e sublime sarebbe una forza per cui, agendo l’attrazione secondo
certe leggi, tali siano le inevitabili conseguenze, essendo creato l’animale,
tali saranno i suoi successori secondo le leggi prefissate della
generazione!” (Taccuino B). L’affermazione
che le cose sono così perché così Dio le ha create non dice nulla a uno
scienziato, ovvero a chi per mestiere si domanda come e perché: quelle
che a Darwin interessano sono le “cause intermedie”. Indipendentemente dalla “verità”
dell’esistenza di Dio, qualsiasi discorso umano su Dio, per esempio
l’attribuirgli la qualità di “creatore”, è una rappresentazione culturale
della divinità. Eccone
alcune: “Dio ha creato l’uomo subito dopo gli animali... l’ha fatto un
po’ peloso perché così poteva essere amico degli animali… dopo un po’ Dio ha
tolto il primitivo e ha creato quello normale... era brutto, gli piaceva poco, era anche un
po’ storto! ” [1]
“Dio… avrà pensato che... quegli animali lì erano un po’ troppo
pochi, e per farli diventare di più, ha messo in moto l’evoluzione”. Quest’ultima,
di un bambino di 8 anni, condivide con Darwin un’immagine di Dio che non
corre dietro alle sue creature momento per momento, ma “mette in moto”, una volta per tutte, un
meccanismo, una dinamica di cambiamento che ha le sue leggi. Nel
1838 Darwin è credente e la sua contestazione scientifica del creazionismo è
un modo per non dare di Dio una rappresentazione volgare: “Il Creatore ha continuato a
creare animali con la stessa struttura generale dai tempi delle formazioni
del Cambriano? Concezione miserevole e limitata” (Taccuino
B). Vent’anni
dopo ne L’Origine delle specie
prevarranno (sicuramente dal punto di vista quantitativo) le confutazioni
“tecniche” della creazione, forse perché Darwin è ormai oltre la svolta della
sua vita personale, quando l’osservazione della natura e soprattutto la morte
della piccola figlia Anna, più della lettura di Malthus, non gli permettono
più di credere a una natura che testimonia la benevolenza del Creatore. Della
portata rivoluzionaria del suo naturalismo
Darwin è ben consapevole, se è vero che nel 1844 scrive all’amico Joseph
Hooker che rendere nota la propria idea sarebbe “come confessare un delitto”. UN
GIOCO SPORCO E
infatti, quando lo fa nel 1859, le reazioni sono violente. Da subito il gioco
si fa sporco, attraverso la deformazione delle idee evoluzioniste; e si gioca
sul terreno delle rappresentazioni. La
teoria di Darwin ha nelle sue radici l’idea dell’antenato comune come spiegazione delle omologie profonde
nell’organizzazione dei viventi; ma gli oppositori di Darwin la rappresentano
con “l’uomo discende dalla scimmia”.
è un modo sicuro per rendere inaccettabili le idee evoluzioniste al pubblico
vittoriano, che del progresso umano, preordinato dal Creatore, cui per questo
si manifesta devoto, e culminante nell’ “Homo
britannicus imperialis” fa il proprio paradigma culturale [2]. La
frase “l’uomo discende dalla scimmia”
è diventato un luogo comune, vale a dire una di quelle “verità” che sono tali
non perché frutto di una esperienza accessibile e condivisa, o documentate in modo inoppugnabile, o filtrate da
un processo critico, ma solo perché fanno parte della cultura che un gruppo
sociale condivide e che quindi ogni nuovo membro della comunità “assorbe”
inconsapevolmente e finisce per ritenere appartenenti alla “natura umana”. Questa
rappresentazione linguistica ha anche un corrispettivo a livello di immagine
in quella che Stephen J. Gould chiama “la marcia del progresso”. Si vedono
uno dietro l’altro da sinistra a destra, una scimmia sulle quattro zampe, uno
scimmione bipede ma curvo e poi via via ominidi sempre più alti ed eretti,
sempre meno pelosi, sempre più somiglianti all’uomo attuale, fino all’ultimo
a destra, che è sempre rigorosamente maschio e bianco. A volte il penultimo a
destra, capellone tozzo e decisamente brutto d’aspetto, è l’uomo di
Neanderthal.
L’idea
di un progresso dell’umanità è profondamente radicata [3]. In
un articolo di presentazione di un libro fortemente antidarwiniano la difesa del darwinismo scientifico è affidata a un
insegnante liceale di latino e greco, specialista di mitologia greca e di
cinema [4],
collocazione professionale che non garantisce la sua competenza scientifica,
ma che ben rappresenta la cultura italiana. La sua “difesa” si basa sull’idea
che nulla è positivo quanto il
sentimento del passo avanti, del migliorare”. L’idea è rispettabile in
sé, una "iconografia della speranza" come la definisce Gould, verso
la quale si può essere umanamente indulgenti, ma, se il contesto è quello di
un discorso scientifico, occorre anche chiarire quale rapporto (non) ci sia
tra progresso ed evoluzione: “... molte delle nostre
immagini sono incarnazioni di concetti mascherate come descrizioni neutre
della natura. [...]. Suggerimenti per l’organizzazione del pensiero vengono
trasformati in regolarità stabilite in natura. Congetture e supposizioni
diventano cose. Le iconografie dell’evoluzione tendono tutte - a volte
rozzamente, altre volte in modo più sottile - a rafforzare un’immagine
confortevole dell’inevitabilità e superiorità umana. La versione più forte –
quella della catena dell’essere o della scala del progresso lineare – ha una
storia antica, pre-evoluzionistica. [...] La marcia del progresso è la rappresentazione canonica
dell’evoluzione: l’unica immagine che venga afferrata immediatamente e
compresa visceralmente da tutti.” (S.J.Gould, La vita meravigliosa,). Darwin
vive in un ambiente culturale dominato dal paradigma del progresso: “Il progresso, quindi, non è un accidente, ma
una necessità. La civiltà non è un prodotto dell'arte, ma è parte della
natura...” (H. Spencer, Social Statics, 1851) Ma
sul progresso Darwin la pensa molto diversamente da Spencer: “La
selezione naturale, o sopravvivenza del più adatto, non comporta
necessariamente uno sviluppo progressivo – essa si limita a trarre vantaggio
da quelle variazioni che si manifestano spontaneamente e risultano
vantaggiose per ciascun vivente nei suoi complessi rapporti con l’ambiente” (L’origine delle specie, 1872). Un
pensatore in controtendenza, solo contro tutti? Darwin è uno scienziato
naturale e qui sta esercitando la sua professione che, pur essendo immersa
nell’ambiente culturale della società, costituisce anche un contesto
specifico. "In parte eliminando i meno sviluppati e
in parte sottoponendo i sopravvissuti all'incessante disciplina
dell'esperienza, la natura assicura lo sviluppo a una razza che sia in grado
di comprendere le condizioni di esistenza e insieme di agire su di
esse." Sono
parole di Spencer e non di Darwin e risalgono al 1851, prima de L’origine delle specie: è bene tenerlo
presente. ANCORA
E SEMPRE IL NONNO SCIMMIA A
pag. 26 de Il Giornale di Lunedì 3
dicembre 2007, la presentazione del libro della moglie di Alberoni [5] Il Dio di Michelangelo e la barba di
Darwin inizia così: “Discendiamo
davvero dalle scimmie?”. Come risulta chiaro dal testo dell’articolo, si tratta
di una domanda retorica che serve ad attribuire ai “cattivi maestri della ‘darwinolatria’ ” l’idea che “I nostri progenitori erano scimpanzè”. La
teoria dell’evoluzione ci dice che le scimmie, nel senso degli animali che
noi attualmente conosciamo, in particolare i primati come gli scimpanzè, non
sono gli antenati dell’uomo, ma
suoi “cugini”, ovvero animali che hanno con gli uomini antenati comuni. Ma
l’uomo ha antenati comuni anche con i topi e le banane, come si deduce dal
fatto che condivide con il topo l’85% e con la banana il 40% della sequenza
nucleotidica del DNA. Tutto sta nel determinare quanto questi antenati comuni
siano lontani nella successione delle generazioni e
quindi nella genealogia dei viventi: oggi sappiamo che quelli con le scimmie
antropomorfe sono vissuti 7 milioni di anni, 200-300 mila generazioni, fa. Sono passati 150 anni, ma la prima mossa retorica contro Darwin
e l’evoluzionismo è sempre la stessa: deformarne le rappresentazioni. E anche
la seconda è come da copione; l’articolo citato infatti così prosegue:“La selezione naturale secondo la legge
dell’evoluzione va applicata anche per sopprimere i più deboli, i meno
fortunati, gli handicappati, magari prima che nascano?”, dove si
tracciano legami arbitrari tra selezione naturale - selezione eugenetica –
aborto, per rendere le presunte teorie evoluzioniste inaccettabili;
l’evidente evocazione del nazismo viene esplicitata poco più avanti
nell’articolo dalla Alberoni: “non è un
caso che il darwinismo abbia prodotto aberrazioni come il razzismo, il
classismo, l’eugenetica, il peggior capitalismo, la discriminazione
biologica”. Per
l’evoluzionismo darwiniano tutti gli
uomini hanno un antenato comune con le scimmie e tutti gli uomini hanno una comune origine africana. Negli
stadi di calcio uno degli insulti razzisti più usuali rivolti a giocatori di
colore consiste nell’imitare atteggiamenti scimmieschi. |